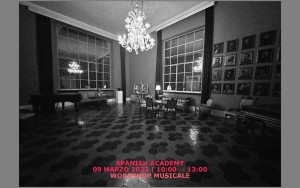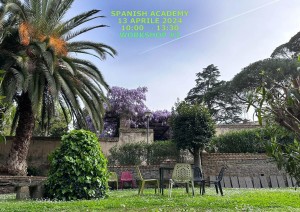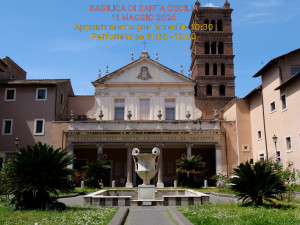ALONSO GIL – Processi 151
ALONSO GIL, I FANTOCCI DI ROMA
REAL ACADEMIA DE ESPAÑA EN ROMA
PROCESSI 151 | MOSTRA FINALE DEGLI ARTISTI E RICERCATORI RESIDENTI, STAGIONE 2023/2024
20 giugno 2024
I FANTOCCI DI ROMA, IL PROGETTO
Mi sono basato sul significato del termine italiano consapevolezza, che potrebbe essere tradotto come coscienza della realtà o coscienza dell’ambiente, e durante la mia permanenza a Roma ho posato il mio sguardo e messo al lavoro la mia macchina creativa in relazione agli esclusi dalla società, quella parte di mondo che generalmente ignoriamo perché non vogliamo vederla, in quanto la sola vista speculare ci fa girare la testa dall’altra parte.
La città come paradigma di convivenza umana rappresenta una promessa ai suoi cittadini di una vita basata sull’inclusione emancipatoria. Tuttavia, questa forma di socializzazione sta subendo ora una drastica interruzione in cui prevale l’esclusione.
In parallelo, ho dipinto una sorta di nuovi comandamenti, a mo’ di haiku, che ci esortano a vivere un’esperienza di vita piena e liberatoria.
PORCA MISERIA, ALONSO GIL Y RUBÉN OJEDA GUZMÁN
Porca Miseria è il titolo di una mostra concepita per essere presentata presso la norcineria Iacozzilli a Trastevere, nei pressi della piazza di San Cosimato. Le opere realizzate erano state pensate per essere circondate da prosciutto, salsicce, polpette, guanciale e, soprattutto, porchetta. Tuttavia, avendo sfidato le autorità italiane, la mostra non ha mai avuto luogo.
Porca Miseria è un’espressione colloquiale di stupore, rabbia, fastidio o delusione. È un modo molto italiano di maledire la sfortuna che si usa quando qualcosa va storto e denota frustrazione o disagio. D’altra parte, per noi era evocativo anche l’elemento del porco e della carne, in quanto temi ricorrenti nel nostro lavoro.
Grazie ai nostri interessi comuni e alla vicinanza dei nostri argomenti artistici, abbiamo instaurato una dinamica di produzione collaborativa che, nella maggior parte dei casi, ha dissolto l’autorialità. Dopo aver messo in piedi una sorta di laboratorio di argilla, luci, assemblaggio di oggetti trovati e readymade rimaneggiati, sono cominciate a fiorire opere che strizzavano l’occhio al selvaggio, al cannibalismo, al caso truccato, il tutto avvolto nel fumo nero emanato dalle nostre teste.
I pezzi ora esposti a Processi 151 sono diventati documenti di ciò che è diventata una voce inespressa di una grande mostra.
SU ALONSO GIL
Alonso Gil (1966) è un artista le cui pratiche in diversi formati, tipologie e discipline offrono una concezione generale dell’arte e dell’artista non soggetta a categorizzazioni impermeabili.
Dalla fine degli anni Ottanta lavora in vari contesti di sperimentazione sociale in progetti che coinvolgono diversi collettivi, stabilendo un processo di lavoro comune.
Ha tenuto mostre personali presso La Sala AtínAya di ICAS (Siviglia); Espacio Santa Clara ICAS (Siviglia); CICUS (Siviglia); The Anti-Personnel Mine BanConvention (Oslo); CAAC (Siviglia); ARTifariti, Tinduf (Algeria); Meiac (Badajoz); Museo Ex Teresa Arte Actual (Città del Messico). E nelle gallerie Buades e Formato Cómodo (Madrid); Berini (Barcellona); Cavecanem (Siviglia); 38 Langham Street Gallery (Londra); Kobochika (Tokyo) e AscanCroneGalerie (Amburgo).
Ha partecipato a mostre collettive presso il Núcleo de Arte, Maputo (Mozambico); MUSAC (León); CDAN (Huesca); NIV Art Gallery, New Delhi; NuitBlanche (Toronto); Miam, Séte (Parigi); Creative Time (New York); Manifesta 4 (Francoforte) o BIACS (Siviglia).
Ha sviluppato opere nello spazio pubblico come Canteminación, Cáceres Abierto, (Cáceres); Graffiti Celestial (Córdoba); Tunning Cofrade, Intervenciones en Jueves 08 (Siviglia) o Guantanamera, Madrid Abierto (Madrid).
Ha collaborato a pubblicazioni come Refractor, La Infiltración, Revista de Occidente, PromotionalCopy, EarthFirst e Vacaciones en Polonia.
Web: https://www.alonsogil.com
Instagram: @alonsogil_7